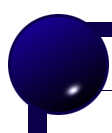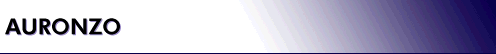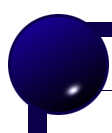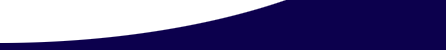|
IL CADORE DEGLI EMIGRANTI
PROTOSTORIA, ESSERI FANTASTICI E SUPERSTIZIONI DEL CADORE
Protostoria e Storia
Dopo la recente scoperta, avvenuta il 19 marzo 2000 da parte di Elio Vecellio Galeno in Località Tarin di Auronzo, di alcune lamine di bronzo contenenti iscrizioni protostoriche e di due dischi, anch'essi di bronzo, rappresentanti due divinità, sappiamo con certezza che gran parte del Cadore era abitato da popolazioni protostoriche di probabile origine indoeuropea. La memoria degli anziani racconta di Boschi Sacri, di Divinità dell'Acqua, di Geni o Folletti abitanti le grotte e le sommità delle montagne, di un profondo rispetto per l'ambiente naturale, perché tutto ciò che la natura della montagna elargiva, era ritenuto dono divino, anche dopo l'avvento del Cattolicesimo.
I primi abitanti stabili di queste valli, che io amo definire Catubrìnos, per distinguerli dai Paleoveneti nei quali gli studiosi tendono a identificare tutte le popolazioni protostoriche del Veneto, possedevano cultura e tradizioni proprie, simili a quelle degli altri popoli che hanno abitato le altitudini del mondo.
La natura in montagna è sempre stata molto avara: il ritmo della vita era scandito dal lavoro nei boschi, dal pascolo delle greggi fin sotto le crode, dai gelidi inverni con copiose nevicate che ricoprivano montagne e villaggi per quasi sei mesi all'anno, da frane e slavine, un ritmo nel quale gli stessi oggetti e utensili in uso nella vita quotidiana erano completamente diversi da quelli utilizzati dalle genti di pianura.
La specificità della montagna riveste un ruolo molto importante anche nella ricerca archeologica e dovrebbe essere condotta da chi conosce usi e costumi dei popoli delle altitudini, per non rischiare di cadere in interpretazioni sbagliate che rischiano di travisare la vera storia di queste montagne. L'orgoglio e la dignità che hanno contraddistinto nei secoli la Gente di Cadore, deriva da un' originalità storica di popolo fiero e libero, autogovernatosi attraverso l'istituzione delle Regole, un popolo discendente da una civiltà antichissima che meriterebbe di essere indagata a fondo.
Alcuni studiosi e addetti ai lavori hanno sottovalutato la protostoria in Cadore, limitandosi a prendere atto dei rinvenimenti di Lagole come un fatto casuale, ma quel che è peggio hanno tacciato di incompetenza e di scarsa affidabilità tutti coloro che nei secoli scorsi, hanno fatto ricerche sull'argomento.
Pierio Valeriano, Cesare Vecellio, Giuseppe Ciani, Venanzio Donà e Alessio De Bon non erano né ciarlatani né visionari, essi hanno trascorso parte della loro vita ad interrogare ed ascoltare gli anziani, a decifrare antichi documenti ora introvabili, a cercare ed esaminare reperti archeologici, alcuni dei quali venuti alla luce casualmente, per tramandarci le conoscenze faticosamente acquisite attraverso i loro scritti.
Ora che le ricerche archeologiche stanno dimostrando l'assoluta veridicità delle loro intuizioni, è necessario rileggerli con maggiore attenzione, per trovare le tracce che possono condurci a nuovi e importanti rinvenimenti.
Pierio Valeriano (celebre filosofo, professore di eloquenza all'Università di Roma, autore del volume "I Geroglifici", nato a Belluno il 3 febbraio 1477, morto nel 1558), in "Antichità Bellunesi" ha scritto:
"Ottanta stadi all'incirca separano Santo Stefano da Gogna, alla confluenza con l'Ansiei, fiume di poco minore. E già il Piave scorre rigonfio prima di toccare l'antichissimo centro alpino che ancor oggi conserva quasi inalterato il suo primitivo nome, Euganea…Partito di qui, dopo 44 stadi circa, gli si unisce il torrente Boite (in un antico documento il fiume Ansiei, nel tratto da Giralba a Treponti veniva chiamato Boite, da cui le famiglie Boite e Vecellio Boite di Auronzo che abitavano nella borgata Zardus vicino al fiume), che nasce dal Monte Mesorina - posto come indica il nome greco, all'incirca nel mezzo delle Alpi Noriche - lambisce Aurontii (Auronzo), villaggio ben noto per le sue miniere di piombo, e si fa quindi strada fino al Piave. La località in cui i due corsi d'acqua si uniscono si chiama Treponti.
Qui infatti tre ponti, il cui accesso è contiguo su una delle rive, sono rivolti, oltre il fiume, in tre direzioni diverse: uno verso la Carnia, l'altro dalla parte dei Taurisci, il terzo nel Noricum mediterraneo. Accolto il Boite a compagno di viaggio il Piave raggiunge, di lì a due miglia, il villaggio di Lozzo e, dopo quattro, il ponte cidolo, entrambi sulla via Norica. Sulla via Carnica, invece, è Lorenzago da cui ha inizio la strada che porta alla Mauriam.
Nei pressi del cidolo è il villaggio di Duomilium (Domegge; a Crodola di Domegge nel 1865 furono rinvenute un ascia e un falcetto di bronzo e sul prato della chiesa di San Giorgio un cranio con uno spillone ed un circoletto sempre di bronzo). Tre miglia più a valle sorge, su un alto colle, un castello che è il luogo più famoso di questa regione. Ivi è l'assemblea cittadina degli amministratori e dei maggiorenti del paese e la sede del Governo Popolare della Regione: si chiama Plebsque (Pieve) e dell'ingegno e della attività di quegli uomini abbiamo già parlato nella precedente conferenza. Dopo questa città, 15 stadi circa più a valle, si incontra il popoloso villaggio di Pinarolanus (Perarolo). Qui un altro fiume, chiamato anch'esso Boites, giunto in prossimità di Pinarolo (Perarolo) attraverso aspri passaggi montani (nasce nella valle d'Ampezzo e scorre sotto il castello detto da esso Botestagno) precipita al piano, a poca distanza dal Anaxum (Piave), gettandosi giù impetuoso da un alto bastione; e quindi ristretto dentro un grande canale artificiale, con la corrente sorretta e contenuta da un solidissimo ininterrotto argine, viene condotto al fiume vicino". Il Canonico Giuseppe Ciani, nella storia del Popolo Cadorino ha scritto:
"ma a Treponti, ove l'Ansiei si abbraccia e si mesce nel Piave, torreggiava l'ampio e mobilissimo castello che portava il nome del luogo: io stesso ne vidi i ruderi ora dispersi dagli auronzani, né d'altro vi resta ancora che la traccia del fosso profondo in cui entrate le acque del Piave rendenvalo inaccessibile… Ma nella parte opposta il piccolo Ansejo or lambe mansueto, or percuote sdegnoso il piede ad altissimi e ripidissimi monti che li si levano a destra, ove incespugliati ed erbiferi, opportuni al pascolo e sì alla caccia, esercizio e vita di popoli liberi; a Settentrione, lungo il fiume, la via ai Vici degli Ebrodunci o Aurunci, come furono detti da poi, consanguinei dei Taurisci.
Quest'oppido da secoli scomparve: spessi abeti, e qua e là ingenti macigni, non sappiamo come, né quando lanciati, ne occupano il luogo. Tale la tradizione mantenutasi costantemente nelle succedentisi età, tramandata dagli avi ai nipoti: ci può essere Storia che non si fondi anche sulle tradizioni?
Cesare Vecellio (pittore, cugino del più celebre Tiziano, autore de "Gli Habiti Antichi e Moderni", vissuto dal 1530 al 1600), fa certi che di codesta Agonia, da lui qualificata cittade antichissima, non altro scorgevasi ai suoi giorni, che le fondamenta di un castello e un bagno di acque sulfuree; imboschito il resto del piano, su che stava.
Ricorda ancora molte scritture in podestà di un Odorico Soldano (Cancelliere della Magnifica Comunità di Cadore), personaggio copiscuo e di gran credito nella piccola patria, ed insieme molte medaglie di bronzo ed in argento rinvenute arando la terra in quelle circostanze: testimonio sì le une che le altre della grande antichità dell'oppido cui spettavano.
Senonchè più importante d'ogni altra cosa egli reputa un piccolo cavallo di bronzo, coperto d'una pelle di leone, lavoro di mirabile artificio, in che s'avenne un contadino scavando quivi stesso la terra.
Cesare Vecellio lo vide nella casa de'Mainardi, e non solo lo vide, ma l'ebbe nelle mani; e narra esserli piaciuto moltissimo nella bella maniera de'nostri antichi in questi lavori; aggiungendo che mancatagli un piede: ove ora, e in podestà di chi sia, niun indizio…".
Ho interrogato a lungo gli emigranti su eventuali rinvenimenti di materiale di interesse archeologico avvenuti a Cima Gogna.
Le notizie che ho raccolto parlano di alcune sepolture e molti oggetti, tra cui alcune fibule, punte di lancia, e molte monete.
Tutto materiale disperso, a parte un paio di monete inserite nel catalogo del professor Perucco che dovrebbero trovarsi nel Museo di Belluno.
Ho la speranza che quando verrà attuato il museo archeologico di Auronzo, alcuni di questi oggetti, ora considerati dispersi, vengano consegnati per poter essere esposti.
Giuseppe Ciani, a p. 85 e 86 dell'edizione del 1940, della "Storia del Popolo Cadorino" scrive:
"Onde per diverse vie guadagnate le Alpi soprastanti, sparsisi per le più intime valli, e mescolatosi co' Reti, già prima raccolti in que'luoghi alla guida di Reto loro condottiero, crearonsi una patria novella, una ogni tribù in che erano divisi.
I Caturigi all'incontro scesi per la valle Euganea od Ausuganea ne' luoghi dove Feltre e Belluno, e saliti lunghesso il Piave, incentrantosi nelle angustie dei monti che da essi appellansi ancora; su questi o stanchezza fosse, o ferma speranza che non sarebbero turbati, si posarono. Non deserti que'monti, già da più secoli stanza de'Taurisci, degli Ebrodunci o Aurunci, di Euganei ivi rifugiati, e d'altri piccoli popoli. I quali sembra che senza opposizione accogliessero gli esuli infortunati; piantatisi sui colli che s'alzano in mezzo alla valle, legaronsi in parentela con que'primi, si fusero insieme e costituirono un popolo che denominarono de'Caturigi".
Secondo il Ciani dunque, i Catubrìnos staccatosi dai Reti, scesero lungo l'Adige e attraverso la Valsugana, Feltre e Belluno, seguirono il corso del fiume Piave, risalendolo fin sotto alle Crode delle Marmarole e dell'Antelao, dove si stanziarono, mescolandosi con varie tribù preesistenti, tra cui gli Ebrodunci o Aurunci.
La memoria degli anziani raccontava di un'antica strada romana che saliva dalla pianura veneta e attraverso Pieve di Cadore, proseguiva per Calalzo, Domegge, Lozzo, Auronzo e Misurina, scendeva a Landro e sboccava a Dobbiaco nell'ampia Val Pusteria. Nessun studioso di rilievo ha mai preso in considerazione questa ipotesi, a parte lo storico Giuseppe Ciani che a p. 119 - 120 dell'op. citata scrisse:
"Non improbabile che l'anno medesimo, nel quale ebbe luogo codesto instauramento, se non prima, dalla Claudia Augusta Altinate, ove non lungi dalle Ceparie, presso il Piave, piegatasi verso Feltre, quella derivassesi, che salendo lunghesso il fiume nella valle dei Caturigi, entrava nel Norico e nella Vindelicia.
Certo è che le tradizioni antichissime venute sino a noi ricordano la via Norica nella direzione che indicammo…Sembra che la via Norica, ramo della Claudia Augusta Altinate, che pe' Caturigi metteva nella Vindelicia, procedesse or a manca, or a destra del fiume (Piave) insino al luogo, ove il piccolo Molinà gittasi in esso…il prossimo vico Duomilia, da che Dumilia, in seguito Domeglo, or Domegge, numero quello delle miglia segnate sulla colonna ivi posta; la medaglia ultimamente ivi rinvenuta con l'effige e il nome del primo Valentiniano; il sito quello perciò meglio opportuno, che più centrico, in cui depositassersi le decime; da ultimo le fondamenta di fabriche (case) antichissime, di cui paiono ancora le reliquie.
Dalla mansione, che noi diremo di Lagole (negli anni 1856 - 1862 quando il Ciani scrisse "La Storia del Popolo Cadorino", a Lagole non erano ancora stati effettuati rinvenimenti archeologici importanti), la via inoltrandosi per Dumilia, sottesso il vico di Lucio (Lozzo), e per la valle corsa dall'Anseio (Auronzo), da Mesorina (Misurina), riusciva nel Campo Gelato (Dobbiaco)". Lo studioso calaltino Alessio De Bon, dopo anni di approfondite ricerche, aveva ipotizzato una strada romana che da Altino, seguendo il fiume Piave, attraversasse il Cadore per condurre nella val Pusteria.
Giunti ad Auronzo, egli individuò un percorso che dalla chiesa di San Lucano, attraverso il Col de la Faula e Monte Zovo, raggiungeva il passo Monte Croce Comelico per poi scendere fino a Sesto di Pusteria.
Sono convinto che egli avesse ragione, che un ramo della strada romana seguisse quel percorso, ma credo che la strada principale si snodasse lungo la Val d'Ansiei, Misurina e Landro, fino a Dobbiaco.
Il rinvenimento di un tratto di strada romana, avvenuto l'8 giugno 2000 da parte di Davide Pacitti e del suo aiutante Mauro Maschio, in Piazza Santa Giustina di Auronzo, è una conferma all'ipotesi del Ciani, così come lo è una moneta d'argento di Giulio Cesare rinvenuta molti anni fa da un operaio, su un tratto di quell' arteria in pieno centro di Auronzo.
Durante le ricerche per la stesura del volume "Auronzo Terra di Frontiera", pubblicato nel 1999 dalla Regione del Veneto e dal Comune di Auronzo, grazie a citazioni trovate in alcuni manoscritti e lo studio di antiche mappe, ho rintracciato le tracce del passaggio di quella importante via di transito.
Da alcuni mesi sto studiando il percorso originario con riscontri positivi e spero di concludere le ricerche entro l'anno.
Dobbiamo ringraziare la Direzione della Soprintendenza Archeologica del Veneto e la Dottoressa Giovanna Gangemi per aver promosso le campagne di scavo del 1999 e del 2000, ed il Comune di Auronzo per aver acconsentito a finanziarle.
Senza la loro fiducia, la storia del Cadore si sarebbe fermata a Lagole. Ora -grazie agli ultimi rinvenimenti- abbiamo le prove di insediamenti stabili di epoca romana e preromana anche nella Valle dell'Ansiei.
Il cippo che Luigi Corte Metto di Auronzo ha trovato a Landro nel 1995, cippo che io ho fotografato e pubblicato a p. 28 del volume "Auronzo Terra di Frontiera", riporta la scritta F.R. e il numero XXVII. F.R. potrebbe significare "Finis Raetia", in questo caso ci troveremo di fronte a una scoperta molto importante e rivoluzionaria per la storia del popolo dei Catubrinos.
Il cippo eretto nel punto esatto dove fino al 1582 passava la frontiera settentrionale della Provincia di Cadore, è posto sopra il probabile percorso della strada romana e XXVII sono le miglia che lo separa da Treponti, dove secondo la tradizione sorgeva la mitica Agonia.
Oppure potrebbe essere il numero confinario, ma in questo caso dovevano esserci altri 26 cippi che finora non sono stati trovati. Queste sono solo ipotesi personali che attendono la conferma degli studiosi.
E se l'importante via di transito che sta per venire alla luce fosse la vera Claudia Augusta Altinate?.
Nell'area delle Dolomiti che si estendono dal Brenta fino al Tudaio - Brentoni, la zona che vanta i più nutriti e i più importanti rinvenimenti archeologici è il territorio del Cadore, non l'Alto Adige.
In quasi tutti i paesi attraverso i quali si snodava la strada romana: Valle, Pozzale, Pieve, Calalzo, Domegge, Lozzo e Auronzo, sono state rinvenute delle iscrizioni protostoriche, ma anche fondamenta di case, sepolture, monete e iscrizioni romane.
La ricerca storica e archeologica e lo studio delle memorie tramandate generazione dopo generazione dagli anziani, sono le vie da seguire per arrivare a nuovi e importanti rinvenimenti che ci aiuteranno a scoprire le nostre vere origini.
Un iscrizione romana ritrovata a Belluno nel 1888, contenuta in un cippo fatto erigere da Giunia Valeriana in onore del marito Marco Carminio Pudente, lo cita come "patrono Catubrinorum". Da qui la mia ostinazione a chiamare Catubrìnos i cadorini, e non Caturigi come scrisse il Ciani, o Catubrènes come vengono denominati da Giuliano e Marco Palmieri. Gli Ebrodunci o Aurunci si erano insediati tra il Comelico e Landro, lungo la valle d'Ansiei, dove fin dai tempi antichi si estraeva il piombo e l'argento, e dove ci sono grandi foreste ricche di selvaggina e abbondanti e fertili pascoli.
Il Comune di Auronzo è il più esteso del Cadore, uno dei più grandi Comuni del Veneto, nonostante che negli anni 1582, 1589 e 1752 la Repubblica di Venezia abbia ceduto al Tirolo consistenti fette del suo territorio. Nel 1930 il territorio del Cadore, suddiviso in 22 Comuni era ricoperto da 32239 ettari di bosco. Auronzo da solo ne comprendeva 7002 ettari , che nel 1993 a causa dell'abbandono delle attività silvopastorali sono aumentati a 7886.
Nominato dai tedeschi Eboroentsch o Oberentz, dall'Imperatore Lodovico nel 816 Aurontio, il Leandro scrive Auronch (così in un manoscritto del 1559 conservato presso al Biblioteca Cadorina di Vigo, scritto dal giureconsulto Guido Casoni di Serravalle, Vicario del Cadore dal 1588 al 1560), e Johannes Baptiste Homann nella carta geografica "La Germania Austriaca" lo indica con il toponimo di Aurenz. Nei vari documenti antichi viene denominato Auroncio (così in una pergamena del 1188 conservata nell'Archivio del Comune), e Abruntij (dai pievani di Auronzo fino al 1750). Gli storici dal 1500 in poi scrissero: Ebrontium, Eborontium, Eorontium, Abrontium o Aurontij.
I glottologi e in particolare il professor Giovanbattista Pellegrini hanno sempre asserito che il toponimo Auronzo è di origine preromana e i recenti ritrovamenti protostorici di Tarin gli hanno dato ragione.
Giovanni Candido a p. 11 dei "Commentari De I Fatti di Aquileia", pubblicati a Venezia nel MDXLIIII, scrisse: "Del Monte da la Croce cavasi oro, ove già fu la rocca di Turone, hora spianata. Et piombo in copia di Ebrontio. Dice Strabone che scrisse Polibio essere state anticamente le cave d'oro ne i Taurisci Norici…". Nel 1942 Gianni Brielli ha pubblicato nella rivista Cadore una serie di saggi sulle miniere cadorine. A p. 7 del n° 3 ha scritto: "Antica è Auronzo e di imprecisata età.
Scavi occasionali del secolo scorso, diedero alla luce monete romane, ed in ogni episodio della storia del Cadore appare questo paese che ne fu sempre un massimo centro. Il Cadorino tutto era un tempo terra di legname e di metalli, e la contrada di Auronzo di particolare fama.
Prima che il Senato della Repubblica di Venezia concedesse nella seduta del 1429, la cittadinanza veneziana agli abitanti di queste valli, un documento dell'Imperatore Berengario, del X secolo, parlando d'Auronzo la dice famosa per le sue miniere.
E' pure di quel tempo un atto da cui risulta come, nel 971, i veneziani patteggiarono e s'accordarono in Rialto, coi legati dell'Imperatore d'Oriente per non vendere ai Saraceni né ferro né armi provenienti dal Cadore, commercio normale della Repubblica.
La maggior parte delle miniere erano di ferro, però, se si deve credere a un documento del XIV secolo, dove si parla di un certo Donato Possilio, maggiorente della Comunità, che dilettandosi delle arti metallurgiche ebbe vaghezza di esplorare i monti vicini e ne trovò d'oro e d'argento, si estraevano metalli ben più pregiati. Ottenne questo dilettante metallurgico l'investitura per le miniere scoperte, a patto ne desse alla Repubblica il cinque per cento dei metalli purgati, sì d'oro, sì d'argento o d'altra fatta".
Queste valli furono abitate molti secoli prima di Cristo, sia perché ricche di selvaggina, di abbondanti pascoli, di floridi ed estesi boschi, ma anche perché, come emerge dagli ultimi rinvenimenti di Auronzo, le Crode erano ricche di giacimenti minerari dai quali era possibile trarre le leghe di metallo utili alla fabbricazione delle armi, degli oggetti votivi e degli attrezzi da lavoro.
Un emigrante in Michigan mi raccontò che quando viveva ad Auronzo, durante l'abbattimento di una parete in una galleria scavata nella miniera Argentiera, rinvenne una rete di cunicoli scavati nella roccia dove poteva entrare solo un uomo disteso. In un cunicolo egli trovò un oggetto di bronzo finemente lavorato, la cui descrizione mi ha fatto ricordare il palstaab citato dal dottor Michele Leicht, Procuratore del Re a Belluno, in "Avanzi Preistorici nel Bellunese" del 1871.
Il suo scritto è stato inserito nel volume "Paleoveneti Alpini", e a p. 12 riporta: "Anche qui la chimica potrebbe dirci qualche cosa, essendochè se l'uno di questi palstaab fu trovato non lungi dalle miniere di Valle Imperina, l'altro fu trovato non lungi da quelle di zinco dell'Argentiera".
Una leggenda racconta di un minatore che lavorando sul Monte Rusiana, nei pressi della Miniera Argentiera di Auronzo, scoprì una sorgente dalla quale invece dell'acqua usciva oro liquefatto. Questi fuori di sé dalla gioia corse nella sua casa di Riva da Corte urlando "son deventade siore…son deventade siore", ma quando ritornò sul luogo del rinvenimento con tutta la famiglia, non incontrò più niente, la sorgente era scomparsa.
La curiosa leggenda che ho ascoltato in Argentina è stata raccolta e pubblicata anche da Angela Nardo Cibele in "Acque, Pregiudizi e Leggende Bellunesi", nell'Archivio per le tradizioni popolari. Carlo Felice Wolff è noto per le approfondite ricerche sulle leggende, cultura e tradizioni delle Dolomiti.
Tra le leggende che ha raccolto in Cadore, spicca quella di "Tanna la Regina de i Crodères". Abitavano i Croderès sopra le miniere Argentiera e Rusiana e il palazzo di ghiaccio della regina sorgeva sul Cimon del Froppa, la cima più alta delle Marmarole.
I minatori e i montanari che lavoravano nelle valli sottostanti potevano valicare i confini del suo regno soltanto una volta all'anno, in quello che veniva definito il giorno di calma.
I minatori ne approfittavano per estrarre dai fianchi delle Marmarole grandi quantità di oro e di argento, senza temere di rimanere sepolti da qualche valanga o da grossi massi fatti cadere appositamente dai fianchi delle montagne. Solo una leggenda? O forse veramente un tempo dalle Marmarole si estraeva l'oro?
Le leggende che ho ascoltato da bambino contenevano sempre un po' di verità, alcune sono state confermate anche dalle ricerche archeologiche.
Ma dell'oro in Val d'Ansiei finora non è stata trovata nessuna traccia.
Gli anziani hanno sempre raccontato di antichissimi insediamenti sia di qua che di là del fiume Ansiei, i ritrovamenti avvenuti in varie epoche, soprattutto nel secolo scorso e non ufficializzati sembra dar loro ragione.
Resta ancora da scoprire il villaggio che da Pian Da Barco si estendeva fino alla Mason sulle pendici meridionali del Monte Ajarnola, vicino ai giacimenti minerari di Pian Da Barco, Larieto e Grigna. La memoria degli anziani racconta di una grande frana che ha spazzato via tutto: in basso c'è una località denominata "la lavina dell'Ebreo", dove si ritiene sorgesse un castello.
Là secondo la leggenda, viveva la madre di "Valentin l'pore forsenin" che, andata a servizio nel castello, divenne l'amante del "Principe". Suo figlio Valentin, rimasto orfano del padre, un minatore morto in seguito al crollo di una galleria, salì dalla borgata Rithiò, fino al castello nella speranza di essere accolto dalla mamma. Questa fece finta di non riconoscerlo e lo respinse. Affranto dal dolore, senza forze perché erano parecchi giorni che non mangiava, Valentin trascorse la notte a piangere steso a terra fuori dalla porta del castello, mentre si scatenava una bufera di neve.
Al mattino seguente alcuni minatori, mentre salivano per andare al lavoro alla miniera di Pian da Barco, s'imbatterono in un mucchio di neve a forma di essere umano. Lo scavarono in fretta con le mani, ma purtroppo per il povero bambino non c'era più niente da fare: era morto assiderato. Costruita una portantina con rami d'abete lo trasportarono nella sua misera casetta in riva al fiume Ansiei dove oggi sorge il Capitello dedicato alla sua memoria.
Mentre le donne della borgata recitavano il rosario davanti alla salma di Valentin, un grande boato scosse tutto il paese di Auronzo, una frana staccatasi dalle pendici del Monte Ajarnola spazzò via il castello punendo così la sciagurata madre che per correre dietro alla ricchezza aveva rinnegato suo figlio.
Molte leggende raccontano di minatori che estraevano oro e argento dalle viscere dei Monti di Corallo. In una di queste, riproposta da Bruna Maria Dal Lago nel volume "Il Regno dei Fanes", troviamo scritto: "del regno incantato dell'Aurona, un regno sotterraneo chiuso da due porte d'oro, con le caverne piene d'oro e di pietre preziose che persino l'acqua che le bagna esce color oro, e le pecore che si abbeverano sono famose per i loro denti d'oro" E' la stessa leggenda raccolta e scritta da Carlo Felice Wolff e pubblicata nel volume "L'anima delle Dolomiti" dalla casa editrice Cappelli nel 1967.
La sorgente d'oro scoperta da un minatore che lavorava alla miniera Argentiera e poi mai più ritrovata, è una leggenda che ho ascoltato in Argentina ma che era ben conosciuta anche ad Auronzo, perché, come ho scritto sopra, era stata raccolta e scritta dalla Nardo Cibele già alla fine del 1800. Una leggenda che ricorda vagamente il regno dell'Aurona, il paese delle miniere e dei misteriosi tesori.
In seguito ai numerosi ritrovamenti archeologici abbiamo acquisito la certezza che in Cadore viveva una popolazione che conosceva la scrittura e che estraeva e lavorava i metalli già mille anni prima di Cristo.
I più importanti rinvenimenti archeologici dell'area Ladina che va dalla Slovenia ai Grigioni, sono avvenuti nella parte orientale, soprattutto in Friuli e in Cadore, peccato che il Wolff si sia interessato solo marginalmente a quest'area, altrimenti avremmo potuto sapere molto di più sulla cultura e sulle tradizioni dei primi abitanti di queste valli.
Il toponimo Auronzo assomiglia molto a quello di Aurona, località che Carlo Felice Wolff colloca nei pressi del passo Pordoi, come ricordano Giuliano e Marco Palmieri nel volume "I Regni perduti dei Monti Pallidi". Il volume è molto interessante, perché estende i limiti territoriali del regno dell'Aurona oltre la leggenda, con importanti considerazioni di carattere archeologico e minerario.
Peccato che quando lo hanno pubblicato non fossero ancora stati rinvenuti gli straordinari reperti protostorici di Auronzo, altrimenti nelle loro pagine il bacino minerario di questa località avrebbero avuto ben altro rilievo. Le analisi di laboratorio hanno confermato che il bronzo si può ottenere fondendo insieme il rame con lo stagno ma anche fondendo il rame con il piombo. Molto bronzo romano è stato ottenuto con quest'ultimo procedimento.
Ecco quindi emergere con forza l'importanza dei giacimenti minerari di piombo della Valle d'Ansiei utilizzati anche in epoca romana e probabilmente anche in quella protostorica. Gli emigranti mi hanno parlato spesso di inspiegabili ritrovamenti di pani di piombo avvenuti mentre vangavano i campi, ma anche nei prati e nei boschi. Accertato che gli insediamenti protostorici e romani in Cadore erano dovuti anche a ragioni economiche, ora bisognerà approfondire le ricerche per verificare se la lavorazione e la fusione del bronzo avvenisse in loco o se invece il piombo venisse trasportato altrove.
I vescovi di Auronzo
Da bambino ho ascoltato molte leggende su Attila e sugli Unni che nel 452, dopo aver distrutto Aguntum (nei pressi di Lienz), misero a ferro e fuoco il Cadore per poi scendere nella piana veneta ad assediare Aquileia. Gli anziani menzionando la fame di Gogna intendevano raccontare delle difficoltà incontrate dagli Unni durante l' attacco sferrato al castello di Gogna, difeso naturalmente dal profondo solco formato dall'incrocio del fiume Ansiei con il Piave, tanto che dovettero assediarlo per giorni e gli occupanti del castello si arresero soltanto perché avevano esaurito tutti i viveri.
Una emigrante in Argentina mi raccontò di aver ascoltato da suo nonno che il vescovo di Ebrontium, avvertito dell'arrivo di Attila, fuggì da Auronzo per rifugiarsi nel castello di Agonia perché ritenuto l'unico luogo sicuro. Durante l'assedio degli Unni, vista la malaparata, riuscì a sottrarsi alla cattura scappando attraverso un tunnel sotterraneo che conduceva alle sorgenti di acqua sulfurea presso l'Ansiei. Poi si dette alla macchia nei fitti boschi, portando con sé tutte le antiche scritture del popolo degli Ebrodunci. In Argentina ho ascoltato la leggenda di un popolo che al comando del re Ebrod, fuggì dall'Asia e seguendo il corso del Danubio, della Drava, e della Rienza, si stanziò a Landro, Mesorina e nella valle dell'Ansiei.
Un popolo che conosceva bene l'arte di forgiare i metalli, che conosceva la scrittura e che si fermò tra le Crode del Cadore perché ricche di selvaggina e di minerali, ma anche per la bellezza dell'ambiente naturale e perché era l'unico luogo tranquillo incontrato nella lunga cavalcata dal Caucaso alle Alpi.
I recenti rinvenimenti archeologici di Tarin e della Piazza Santa Giustina, testimoniano l'importanza avuta in passato dal centro alpino di Auronzo, e inducono a ristudiare le affermazioni di alcuni storici che ritennero di collocare il vescovo Ebrociense Aaron nella valle d'Ansiei.
Giovanni Candido nei "Commentari de i Fatti d'Aquileia" stampati a Venezia nel MDXLIII col privilegio del Sommo Pontefice Paolo III e del Senato della Serenissima, scrisse dell'importanza delle miniere di piombo di Ebrontio (Auronzo), dell'antica strada di Botastania (Botestagno) dei Vindelici, per la quale entrarono i Barbari, individuando il fiume Anaxo descritto da Plinio non nel Piave ma nell'Adige che fino al 1600 si pensava avesse le sorgenti nel lago di Mesorina.
Scrive infatti il Candido: "Ma giudico che le parole di Plinio del maggiore e del minore Tiliavento cos' le abbino da intendere e leggere, che chiamasse egli il minore Tiliavento per proprio nome Anaxo, quando che dietro a quel monte vicino a Tobliaco villa, escono L'Athige e Dravo". A p. 44 ha scritto:
"Ha il Patriarcato d'Aquileia vescovi Suffraganei, il Trentino, il Padovano, il Veronese, il Vicentino, il Trevisano, quello di Concordia, di Ceneda, di Feltre, di Belluno, di Parenzo, di Pola, di Trieste, di Petene, di Giustinopoli, di Emona fino a Savo. Hanca etiandio quello di Mantova, di Como. Eransi altri vescovi a nostra era annullati, Caravacense, Ebrociense, che è un borgo vicino a Cadubrio, e fino ad hora conserva il nome, e molti vestigi d'antichità vi si veggono".
A pagina 42 raccontando del viaggio del Patriarca d'Aquileia Paulino alla corte di Carlo Magno per dolersi delle difficoltà in cui si trovava la chiesa d'Aquileia e quasi tutto il paese, dei privilegi e delle terre ottenuti dall'Imperatore, privilegi e terre confermati successivamente da Lodovico, Lothario, Carlo, Berengario, Ottone, Federico I, Ottone IV e altri; il Candido scrisse che Carlo Magno nel suo testamento lasciò alla chiesa di Aquileia la terza parte dei suoi tesori e masserizie: "regali che fussero divise ne le chiese Romana Melanese, Ravvenate, Gradense, Coloniese, Magontina, Gianuense ovvero Salzpurgense, Treverense, Senonense, Vesontiense, Lugdunense, Rothomagense, Remense, Arelatense, Vienense, Durantasia, Ebrodunense, Burdegalense, Turonense".
Anche l'ecclesiastico De Rubeis, nella sua opera "Monumenta Ecclesiae Aquilejensis Universo Terrarum Orbe Scriptorum Calamo Delineato" prendendo dallo storico Alfonso a Varea ha scritto: "Aurontium, URBS in Gallia Cisalpina in Venetia Regione prope Anaxum, nunc Auronzo, castrum domini Veneti in Cadubrio Forojulii ad radices Alpium et limites Comitatus Tyrolis".
Il De Rubeis sfogliando i manoscritti della "Cronaca Gradense" e della "Cronaca Altinate", aveva trovato che nel Sinodo tenuto a Grado dal Patriarca Elia nel 579, tra i convenuti c'era anche il vescovo Aaron della Santa Chiesa Avoricense ed esattamente: "Ego Aaron S. Ecclesiae Avoricensis Episcopus". A p. 31 di "Udine Illustrato", nel 1665, il Capodogli scrisse: "Avevano anche i Patriarchi d'Aquileia la superiorità medesima sopra quelli di Mantova e di Lubiana. Ed inoltre anche d'altri estinti, ch'erano quelli di Cavazzo posto nel primo ingresso della Cargna; l'Ebrociense verso i confini del Cadore, di Rovigno, e di Tersacco nell'Istria, e quello di Udine che nel 803, fu donato dall'Imperatore Carlo Magno alla chiesa d'Aquileia, essendo Paolino II di questo nome Patriarca".
Venanzio Donà richiama questo documento del Capodogli, e ricorda di una iscrizione sepolcrale "Episcopus Euganee" trovata nei primi anni del 1700 dietro al vecchio campanile di Villapiccola.
Per questo motivo lo colloca ad Agonia e non ad Auronzo.
Giuseppe Ciani in una nota alla sua "Storia del Popolo Cadorino" scrisse che del Episcopato di Auronzo trattò anche Don Leonardo Zanella Garofalo, dotto Sacerdote cadorino, già Parroco di Godega nel Cedenese, in una Dissertazione manoscritta "Sull'origine, progresso e vicende dell'Arcidiaconato di Cadore", di cui il Ciani possedeva una copia. Il canonico di San Candido Josef Resch che studiò a fondo tutti i documenti di Frisinga, nel 1772 pubblicò l'opera: "Aetas Millenaria Ecclesiae Aguntinae in Norico sive Inticensis in Tyroli Insignis Collegiatae ad SS. Candidum et Corbinianum" che faceva seguito agli "Annales Ecclesiae Sabionensis et Brixinensis" edita nel 1755, affermando che l'Episcopato di d'Auronzo era attivo almeno fino al 816, perché in quell'anno l'imperatore Lodovico in un documento che trattava dei beni della chiesa di Frisinga (San Candido) scrisse: "Aguntum in finibus Episcopatus Aurontii".
Molti altri scrissero dell'Episcopato di Auronzo, da Carlo Troya che nel "Codice Diplomatico Longobardo" stampato a Napoli nel 1852, pone il vescovo Aaron in quel di Cadore, a Carlo Cipolla che in " Della Giurisdizione della Sede Milanese nella Venetia et Histria" stampato a Milano nel 1897, ricorda il Vescovo d'Auronzo presente a Grado nel 579.
Lo storico cadorino Don Giuseppe Monti, a pagina 12 del manoscritto conservato presso la biblioteca di Vigo di Cadore ha scritto: "Elia Patriarca d'Aquileia si mostrò cattolico: radunò in Grado il Concilio di 20 Vescovi fra i quali Aaron Episcopus S. Ecclesiae Avoricensis.
La sede del vescovo è incerta. Alcuni credettero Auronzo in Cadore. Non è azzardata la supposizione. Il Decreto emanato dal Papa Zaccaria nell'anno 743, per negare la sussistenza, invece la favorisce perché i Sacri Canoni che non permettono che siano ordinati vescovi nelle chiese e piccole città per non avvilire la dignità Vescovile accerta che vi fossero e vennero inibiti. Che poi Aronne fosse stato Vescovo di Auronzo io pure lo nego, e mi unisco a quelli che lo credono vescovo di Albona in Istria.
Il Patriarca Elia dopo il Concilio si appalesò qualora, furioso e scismatico". Alcuni anni fa, incuriosito dal fatto che molti studiosi avevano scritto sull'argomento, ho fatto fare alcune ricerche negli Archivi del Vaticano, ma senza risultato. Pare che il presunto vescovo d'Auronzo, nel 558, abbia aderito allo scisma contro il Vaticano che sancì il distacco da Roma dei vescovi di Venezia e della Rezia.
Il canonico Josef Resch afferma che la firma del vescovo Ebrociense da lui identificato come vescovo d'Auronzo, apparisse in calce a un documento scritto nel 591 dai Vescovi scismatici della Rezia. Il Cadore è stato per secoli una Provincia separata sia da Belluno che da Feltre.
Mi sembra quindi realistico che anche la chiesa Cadorina possa essere stata retta da un vescovo. Una antica tradizione che ho raccolto negli USA vuole che il vescovo Lucano, poi dichiarato Santo, sia stato uno dei vescovi del Cadore. L'Episcopato avrebbe avuto la sede in Auronzo. Nella chiesa di Santa Giustina, a Villagrande di Auronzo c'è un dipinto che lo raffigura e la chiesa di San Lucano a Villapiccola è dedicata al suo nome.
La cima più alta dei Ciadis de Mesorina si chiama Ciadin de San Luguan, e le memorie degli anziani raccontano che egli si ritirò su quella montagna in meditazione. La leggenda racconta che il vescovo Luguan fu costretto a scappare da Auronzo, perché incontrò molte difficoltà nell'evangelizzazione di quella popolazione. Un semplice detto che gli anziani ripetevano spesso: "Te sos come Colomban, la schena dura e l'beco san", racchiude una verità storica poco conosciuta.
Correva l'anno 611 d. C. quando tra le Crode del Cadore comparve un frate "Irlandese bello nella persona, assai più nell'animo, d'alto intelletto, di modi amabili, di vita semplicissima di virtude antica: si chiamava Colombano…traghettatosi nelle Gallie, parlamentava ovunque potesse…Veneticorum venienti, et Evangelium praedicandi, consilium jam olim conceperat San Colombanus anno 611.
Per i cadorini abituati a lavorare dalla mattina alla sera per trarre dagli erti pendii ciò che l'avara natura della montagna elargiva, il frate Colombano era molto bravo a predicare "l'beco san", ma non altrettanto ad aiutare i cadorini nel duro lavoro nei campi e sugli alti pascoli "la schena dura".
Questo è un esempio di come, in un semplice detto senza nessun significato, sia invece compendiato un fatto storico di notevole importanza: un ulteriore dimostrazione dell'attenzione che dobbiamo porre nel recepire i racconti, le leggende ed anche i semplici proverbi o detti, trasmessoci dalla memoria degli anziani, perché in essi ci può essere la chiave che ci permetterà di scoprire una parte della nostra storia, della nostra cultura e delle antiche tradizioni.
Una antica leggenda racconta di una grande battaglia avvenuta sotto al Monte Pater (così si chiamava il Monte Paterno anticamente), tra i romani e i barbari che erano saliti lungo la valle della Rienza per scendere a invadere la colonia romana di Ebrontium. Mi è giunta notizia del ritrovamento di un probabile umbone di scudo romano riportante la scritta VICTORIA in alto, trovato proprio sotto al Monte Paterno.
Dopo il probabile umbone di Monte Piana, questo sarebbe il secondo ritrovamento che conferma come le leggende contengano sempre una parte di verità. Ho anche notizie di ritrovamenti di punte di lancia nella parte settentrionale della Croda dei Tre Scarperi.
Le nostre Crode furono abitate molte anni prima di Cristo e questi rinvenimenti sporadici non devono restare fatti isolati, ma essere d'impulso per ricerche sempre più approfondite. Mentre scrivo queste note, insieme a mio figlio Giuseppe, a Eugenio Padovan, all'archeologo Davide Pacitti, a Francisca Irarrazaval Chadwick, a Mauro Maschio, a Giovanni Zandegiacomo Seidelucio e alcuni componenti del Gruppo Archeologico Cadorino, assistiti dagli operai dell'Impresa Monti, abbiamo dato inizio ad alcuni scavi archeologici nella vecchia piazza Santa Giustina di Auronzo.
Finora sono emerse le mura delle antiche chiese, una casa romana, che sembra risalire al primo secolo d. C., alcuni frammenti di lamine di rame e di bronzo, di anfore, lucerne, ceramiche e monete d'epoca romana che ci hanno dato la sicurezza della frequentazione antica, sicuramente romana della piazza e un tratto di strada romana. Appena avuto notizia che stavano per essere appaltati i lavori per la nuova piazza, avendo saputo da alcuni emigranti in USA che a nord est della stessa, nel 1890 c'era stato un importante ritrovamento archeologico, ho avvertito la Soprintendenza Archeologica del Veneto nella persona di Eugenio Padovan. Incaricato di vigilare i lavori, il 29 aprile 2000, a ovest della piazza, dove questa si incrocia con la via Tarin, ho intravisto alcuni sassi tenuti insieme dalla calce a circa 70 centimetri di profondità. Dopo averle ripulite, intuendo che si trattassero di mura d'epoca romana, ho avvertito Padovan e il sindaco di Auronzo Walter Antoniol.
Nei giorni successivi ho continuato a seguire i lavori appaltati alla ditta Monti di Auronzo, aiutando gli operai a riportare alla luce alcuni reperti di notevole importanza, tra cui un grande blocco di pietra squadrato avente al centro un foro a forma di catino del diametro di 40 centimetri e alcuni frammenti di ceramica d'epoca romana e frammenti di una lucerna finemente lavorati.
In seguito con la costante presenza di Padovan, di alcuni volontari del gruppo Archeologico Cadorino e dell'archeologo Pacitti, abbiamo rinvenuto un pavimento di probabile epoca medioevale contenente 5 tombe, le absidi delle antiche chiese e molte fondamenta di mura, alcune di notevole spessore. Gli scavi sono appena iniziati e già si preannunciano ricchi di sorprese.
La chiesa della Villa Grande di Auronzo è molto antica, le vecchie pergamene dicono che era stata dedicata a Santa Giustina, martire padovana, fin dal XIII° secolo. Nel 1247 in occasione del Sinodo dei vescovi a Foro Julii presieduto dal patriarca d'Aquileia Bertoldo, la chiesa d' Auroncio pagò alla chiesa madre la tassa più alta tra quelle stabilite per le altre chiese del Cadore. Il documento è pubblicato a p. 5 del volume I° dei manoscritti di Don Pietro Da Ronco, conservati presso la Biblioteca Cadorina di Vigo di Cadore. A p. 2 degli stessi manoscritti Don da Ronco scrive che già nel secolo VIII e nel secolo IX molti paesi del Cadore possedevano una chiesa propria.
Una pergamena datata 18 agosto 1436 e conservata nell'Archivio Antico del Comune di Auronzo, recita che in tale data si riunirono nel Paveon di Santa Giustina i rappresentanti dei fuochi della Regola omonima, "i quali erano 38 e superavano i due terzi" e sotto la presidenza del marigo Gerardo d'Uliana, deliberarono di dare l'incarico al maestro muratore austriaco Jorio da Lienz, di edificare un campanile in muratura, utilizzando il legname, la calce, le pietre di tuffo e la sabbia messi a disposizione dalla stessa Regola.
Il campanile venne edificato all'interno del cimitero di Santa Giustina e costò alla Regola 115 ducati d'oro. L'atto fu steso dal notaio Giovanni da Chiave fu Domenico di Ampezzo, residente a Pieve di Cadore, con la garanzia fideussoria di Giovanni detto Raselin di San Candido in Pusteria.
Nel volume "Chiese del Cadore" lo storico Giovanni Fabbiani ha scritto: "la chiesa di Santa Giustina vergine e martire è una delle più antiche del Cadore. Si ha notizia di una chiesa finita di costruire nel 1472, era gotica, con l'abside presso il campanile attuale, la facciata ad ovest, occupava la parte a monte della vecchia piazza di Santa Giustina.
L'attuale è del 1772, eretta su disegno di Angelo Del Fabbro di Tolmezzo da Domenico Schiavi suo compaesano. Consacrata il 20 giugno 1790 è la più grande chiesa del Cadore, ad una sola navata, con sette altari in marmo, tutti grandi e belli; imponente e semplice all'esterno, bella all'interno. Accanto sta il campanile, semplice, ma intonato alla chiesa, costruito nel 1436, restaurato nel 1737 e nel 1921".
Lo stesso autore, nel volume "Auronzo di Cadore Pagine di Storia" ha scritto: "Il campanile aveva tre campane, nel 1921 portava ancora i segni dell'antica chiesa e quello della porta che dal coro metteva al campanile; la porta attuale del campanile venne aperta quando si costruì la chiesa odierna.
Nel 1737 il campanile venne alzato su disegno dell'architetto Della Rossa di Belluno".
La mia speranza è che nel proseguo degli scavi sia possibile rinvenire un iscrizione o altro che possa chiarire una volta per tutte se l'antica Aurontium o Ebrontium o Abrontium o Abruntij sia stata un centro alpino di tale importanza, da essere anche sede di un Episcopato. Ancora una volta l'ultima parola spetta ai rinvenimenti archeologici, gli unici in grado di dare una testimonianza concreta alla storia del Cadore.
Cultura tradizioni e superstizioni
Il 20 e 21 marzo si festeggiava l'equinozio di primavera, l'antica Ostera denominata anche festa della giovinezza o festa delle uova che venivano dipinte di rosso per simboleggiare il sole e regalate alle persone care assieme a viole e eriche.
A Villapiccola di Auronzo c'è una valle che sale verso il Col della Faula denominata Val Ostera. Quando si scioglievano le nevi, i ragazzi raggiungevano i pascoli più importanti a fei delin delon co la sampogna (una campanella che veniva appesa al collo degli animali quando erano al pascolo) por ciamà l'erba. Un usanza arcaica che è stata tramandata nei secoli, perché una rigogliosa crescita dell'erba sui pascoli di alta montagna veniva considerata un auspicio positivo per l'economia dei cadorini, che era basata principalmente sulla pastorizia. Il 25 aprile in ogni paese del Cadore si festeggiava l'on salvargo, in quella occasione un uomo scelto da ogni frazione si vestiva di un abito confezionato con rametti di abete bianco, il capo adorno di rametti di faggio e il volto coperto da una maschera di legno. L'on salvargo così agghindato, girava per le contrade del paese emettendo grida gutturali e cantando un antica, ora dimenticata canzone. Il pomeriggio del 30 aprile tutti i ragazzi del villaggio si recavano nel bosco a tagliare tre alberi di abete bianco e dopo averli pelati dai rami e dalla corteccia, li trasportavano nella piazza principale del paese dove venivano issati uno di fianco all'altro, il più alto nel mezzo.
Le misure dei tre maj erano rispettivamente: di 19 metri quello centrale e di 16 metri quelli laterali. Si dava così l'avvio ai festeggiamenti per le Calendemajo, e durante la notte i giovani innamorati ponevano sulla porta o sulla finestra della camera delle loro ragazze un ramo de avedin (l'majo) agghindato con nastri e fiori, quale formale richiesta di fidanzamento. Se una ragazza non accettava, l'innamorato rifiutato appendeva nella piazza una bambola costruita con paglia e stoffa insieme ad una lettera dove scriveva tutto il suo dolore per il rifiuto e la speranza di un ripensamento, talvolta la lettera conteneva anche insulti e calunnie: un modo di vendicarsi per essere stato respinto.
L'indomani, primo maggio, tutti gli abitanti si radunavano nella piazza principale del paese attorno ai tre maj per assistere e partecipare ad una serie di giochi e competizioni tra i rappresentanti delle borgate: la corsa dei sacchi, il tiro alla fune, il tiro al bersaglio e la scalata del majo de medo sulla cui sommità erano appesi salami, pancette, ossocolli e forme di formaggio.
Per rendere più difficile l'ascesa, l'albero veniva abbondantemente unto con gras de seu che lo rendeva molto scivoloso. Il detto ancora in uso in alcuni paesi del Cadore: "Duiesto al majo?" o "I duia al majo", ci riporta all'antica festa.
Tristemente famose le feste del Calendemajo di Auronzo del 1694: Bartolomeo Zarduz, la sera del 30 aprile stava preparando la polvere da sparo per il fucile che avrebbe usato il giorno successivo nella gara di tiro a segno, quando improvvisamente questa s'incendiò. A quei tempi tutte le grandi case del villaggio venivano edificate utilizzando molto legno, secondo il tradizionale stile cadorino, ed erano addossate le une alle altre. Quella notte il vento soffiava forte e in un attimo il fuoco si propagò alle case vicine, per poi estendersi alle altre borgate.
Molte case della frazione di Villagrande furono completamente bruciate, mille persone rimasero senza tetto, ci furono morti e feriti: un disastro. Il 2 maggio si riunirono i Regolieri di Villagrande che decisero di chiedere aiuto al Doge, questi ordinò l'invio ad Auronzo di 100 sacchi di miglio che giunsero però solo il 26 luglio. Il Consiglio del Cadore esonerò i senza tetto dal pagamento delle imposte per 10 anni, ma tutto ciò non bastò, nell'incendio le famiglie avevano perso tutto. Alla fine ben 490 persone decisero di lasciare Auronzo emigrando chi in Friuli, chi in Istria, chi in Austria, chi in Slovenia e Ungheria. Molti di loro non tornarono mai più al paese d'origine.
Fu il primo esodo di massa dal Cadore. Seguendo un antica tradizione, la notte tra il 23 e il 24 giugno di ogni anno venivano accese delle grandi pojate (falò) sulle alture che circondano i villaggi cadorini e ogni nucleo familiare lanciava in aria delle rotelle infuocate.
Altre pojate venivano accese sulla piazza di ogni contrada e la gente girava intorno a queste in senso orario, emettendo grida arcaiche tra le quali il tradizionale "iuffuffui".
Alcuni studiosi hanno creduto di far risalire quest'usanza alla tradizione celtica, ma in attesa di nuovi ritrovamenti che ci facciano comprendere meglio le nostre origini, la definiremo " usanza Catubrina". Nel 1927 il poeta di Pieve di Cadore Aldo Palatini, ha composto una poesia che ci riporta al lancio dei dischi infuocati, una tradizione ormai dimenticata da tempo. La poesia stata pubblicata da Giovanni Fabbiani nell'Archivio Storico di Belluno, Feltre e Cadore:
Il getto del fuoco la notte di San Giovanni
"Un incanto di luci e di profumi Circonfonde l'alpestre primavera: taccion, sospesi nella mite sera, e gli uomini e le belve e i boschi e i fiumi. Soli, nell'alto, stanno alcuni cuori, piccoli e vivi sulla netta crina, che in cielo incide l'umile collina, con giuochi e gridi, cuori che son fiori.
E Gigi un suo disco di legno prende concavo alquanto e carico di ragia: gonfia le gote, soffia su una bragia ed il suo razzo primitivo accende. Arcuando la schiena, indietro tragge il braccio e il pugno, che tien piatto il disco, e, mentre il breve dire io finisco, lo scaglia . E fuggon per ignote piagge gli strani fuochi. E quale, con un breve volo, ricade morto, fra le piante e qual continua il suo viaggio errante e fissità di stella in ciel riceve.
Gettano i fuochi insieme a gara i bimbi, laminando di lucido oro il manto viola della sera, tutto quanto costellato di grappoli e corimbi.
Levansi acuti gli infantili gridi Nell'alto dove il mondo intende anelo Mentre a loro rispondono, nel cielo, trilli di stelle da oscillanti nidi.
Salute amore gioventù s'allegra, l'anima è immersa in onde di velluto: schietto è il sorriso, affabile il saluto, terso il pensiero e la parola integra. Torna il bimbo fra i suoi, col fuoco acceso ancor nel cuore, obbediente e buono e, nella tregua, che pare perdono, da un calmo sonno tutto il mondo è preso".
La vigilia della notte di San Zuane Battista, i ragazzi e le ragazze dei villaggi uscivano sui prati a raccogliere dei grandi mazzi di fiori, fronde di sambuco, malva, camomilla ed altre erbe medicinali che portavano nelle loro case.
Nel tardo pomeriggio salivano verso le alture che fanno corona la villaggio, raccogliendo bracciate di legna secca nei boschi per preparare i falò. Sceso il buio, sulle principali cime e alture del Cadore, dal Tudaio all'Ajarnola, dal Montanel al Froppa fino al colle del Castello di Pieve, dall'alto di Rèvis a Lozzo, alle alture del Comelico, da quelle della Valle del Boite a Cortina d'Ampezzo, ovunque le fiamme delle pojate si alzavano verso il cielo a rischiarare la notte.
Mentre alcuni ragazzi avevano il compito di mantenere i fuochi, altri infilavano i dischi di legno di pino, cosparsi di rasa in un bastone e dopo averli accesi li facevano ruotare finché presa velocità, potevano essere lanciati nel vuoto verso la valle. Qui i bambini e gli anziani stavano con il naso all'insù ad ammirare le scie luminose lasciate dalle thidele infuocate che cadendo nel vuoto, disegnavano una scia luminosa come le stelle cadenti. Allora cantavano: "Tira tira le thidele su le porte de i pagane viva viva San Zuane" Tira tira le thidele su la porta de i cristiane viva viva San Zuane"
Quando il fuoco era ben spento, le ceneri venivano gettate nel vuoto e disperse nel vento quale atto di scongiuro e difesa contro le frane e le valanghe. A mezzanotte tutti i fuochi erano cessati e i ragazzi e le ragazze davano inizio a una festa che durava fino all'alba. Poi con la luce del giorno scendevano a valle.
La tradizione di accendere pojate sulle alture visibili dal villaggio veniva ripetuta più volte in un anno. Quand'ero bambino ricordo che durante la processione di un venerdì Santo, mentre questa si snodava lungo la Riva da Corte, sulle alture circostanti erano stati accesi numerosi falò. Uno era visibile anche sulla vetta del Monte Ajarnola.
Lo sposo più fortunato era colui che il giorno delle nozze stendeva la pelle di un orso davanti all'ingresso della chiesa (gli orsi sono scomparsi dal Cadore nella seconda metà del 1800, ed ora nuovamente reintegrati).
Quando la sposa lasciava la casa per recarsi in chiesa, i giovani della borgata le ostruivano la strada e la lasciavano passare solo dopo aver ricevuto in dono pèta e vino.
Dopo il matrimonio gli sposi dovevano andare nel bosco e, mano nella mano, girare per tre volte consecutive in senso orario attorno a un albero di frassino. Lo stesso giorno la suocera aspettava la nuora sulla porta della nuova casa con una scopa in mano.
Dopo averla abbracciata e averle dato alcuni consigli su come far felice il proprio figlio, le passava la scopa con cui la sposa doveva spazzare la soglia di casa.
Entrate nella stua, la faceva sedere e dopo averle tolto le scarpe, le calzava un paio di scarpete di pezza che lei stessa aveva confezionato.
A tutti coloro che entravano in casa il giorno delle nozze veniva offerto da bere del vino rosso in una scodella di legno che veniva passata di mano in mano in senso orario e ognuno prima di bere doveva dire alcune parole di buon auspicio per gli sposi. Il cibo veniva servito in un grande catino e messo in mezzo alla tavola: tutti mangiavano quindi dallo stesso piatto.
A una donna in gravidanza quando raggiungeva l'ottavo mese la suocera doveva offrire un abbondante marenda da consumare possibilmente nel bosco. Dopo essersi rimessa dal parto, la novella madre doveva uscire in strada e offrire un pezzo di pane al primo uomo anziano che incontrava.
Anticamente in Cadore, dopo il funerale di un congiunto, la famiglia arrostiva dei capretti o degli agnelli che venivano serviti insieme a una fumante polenta, durante il banchetto al quale partecipavano: i familiari, i parenti, gli amici e i vicini della persona defunta.
Coloro che morivano durante la primavera, venivano sepolti adorni di fiori d'erica. Tutte queste usanze le ho lette in un manoscritto conservato da Ida Cattoni in Pennsylvania. Il manoscritto datato 1737 conteneva le tradizioni del Cadore in uso fino a quell'epoca, ed erano state messe per iscritto perché non andassero perse. Non ho notizia di altre copie del manoscritto rinvenute in Cadore.
La memoria degli emigranti ricorda tra l'altro il Col de La Faula (sul Monte Zovo presso il Passo San Antonio), dove secondo la tradizione c'era il bosco Sacro dei cadorini. Mi hanno raccontato che lassù era stato costruito un Paveon dove si riunivano le Regole del Cadore.
Prima della riunione veniva acceso un grande falò di legno di faggio quale buon auspicio per la faula e quando il fuoco era spento, il marigo di ciascuna Regola provvedeva a disperdere le ceneri nel vento. Dopo l'assemblea facevano un gran banchetto con carne di agnello arrostito allo spiedo, poi si dava inizio a una grande festa con giochi, canti e balli.
Alla sera ognuno ritornava al proprio villaggio. Questo avveniva solo una volta all'anno, in occasione dell'equinozio d'estate ed era l'occasione per un gioviale incontro tra gli appartenenti alle varie Regole del Cadore e per i loro familiari.
Lo storico cadorino Mons. Giovanni De Donà, a p. 307 del manoscritto "Cadore 2", conservato presso la biblioteca Cadorina di Vigo, scrisse:
" 1343, Zovo: cioè il giogo tutto prativo, che è fra Auronzo e Comelico, o più propriamente fra Villapiccola di Auronzo da un lato e Padola e Danta dall'altro. Questo Zovo o Giogo presenta un fatto singolarissimo nei fasti delle proprietà e dei consorzi. Non apparteneva nel suo complesso a verun consorzio particolare o determinato, ma era diviso in molte e minute proprietà private di singole persone o di corpi morali, e queste proprietà erano vendibili, alienabili a beneplacito di ciascun possessore.
I possessori poi non erano tutti di uno o due o tre luoghi vicini, come suol essere nei Regolati o territori di tutti gli altri Monti e Comuni del Cadore, ma erano sparsi per quasi tutti i Comuni del Cadore e anche fuori.
Infatti nel 1343 ve n'erano di Costa, di Candide, di Gera, di Santo Stefano, di Auronzo, di Vigo, di Lozzo, di Vallesella, - v'era San Giorgio di Domegge -, ve n'erano di Calalzo, di Pozzale, di Sottocastello, - v'era ser Guecello e i suoi fratelli di Pieve, - ve n'erano persino di Ampezzo, - e v'era persino il monastero di Follina; - e tutti compravano, vendevano, affittavano a chi, e da chi, e come volevano. Ma d'altronde erano tutti legati in una Regola e formavano un Comune a sé, indipendente da Regole o Comuni circonvicini; e avevano il loro marigo che eleggevano essi nelle loro favole, e ch'era legalmente riconosciuto come i marighi di qualunque altro Comune, - il quale ne reggeva e amministrava alcuni affari o interessi comuni…".
Ad Auronzo si raccontava che sotto alcuni boschi, in particolare nei Boschi dei Morti della Val da Rin, e di Somprade, vagavano grossi serpenti nei quali si nascondevano le anime dei dannati. A volte si sentivano gemiti lunghi e penetranti. In quei boschi a volte s'incontravano anche alcuni rami degli alberi a forma di serpe che strisciavano fino ai nidi degli uccellini per incantarli e mangiarli. Molti assicuravano di aver visto alcuni rami di quegli alberi che piangevano.
Ci sono alcuni episodi oscuri che hanno rovinato l'esistenza ad alcune persone che si fermarono a lungo in quei boschi, episodi che non sono mai stati chiariti.
Ad Auronzo si raccontava che un uomo fu condannato a farsi mangiare il cuore da una sorcia. Ma prima di farlo questa gli girò attorno per tutto il corpo fino a farlo rabbrividire, poi gli mangiò il cuore. In Comelico si raccontava di un tale che con il suo zufolo faceva ballare le vipere, molti provarono ad imitarlo ma nessuno c'è mai più riuscito.
In Cadore si usava uccidere le vipere e levare il grasso dalla schiena per usarlo contro i dolori reumatici. Se si veniva morsi da una vipera si doveva bere molto latte e uccidere una gallina nera sventrandola e applicando il cuore sulla parte offesa. In Cadore si raccontava anche della bissa usèla che riusciva a volare grazie a due grandi ali.
A Cortina d'Ampezzo, Borca, Santo Stefano di Comelico, Auronzo e altri siti del Cadore l'incubo diventa un uomo che si chiama Premevenco o Venco, il quale quando non poteva sedersi sul petto e sullo stomaco di qualcuno, si trasformava in un' ape e girava attorno al lume.
A Santo Stefano di Cadore per tenerlo lontano, l'uomo indossava una camicia da donna e la donna quella da uomo. A Candide gli cantavano: "Tornè doman che ve darò del pan, vegnì doman che ve darò pan e sal". A Cortina d'Ampezzo per allontanarlo si stringevano un dito di una mano o di un piede, per fermare la circolazione del sangue.
Le vecchie del Cadore tenevano sempre una granata attraverso l'uscio della cucina per premunirsi contro le streghe in genere, le quali riuscendo a entrare in casa con qualche sotterfugio, sarebbero state costrette a inforcare l'antica cavalcatura rivelandosi nella loro vera identità. Non bisognava mai tagliarsi i capelli e le unghie con la luna calante, né tagliare la lana alle pecore.
Al colmo di luna non si doveva tagliare l'erba né travasare il vino.
Quando un cacciatore all'alba usciva di casa e incontrava una vecchia o una zoppa doveva ritornare in casa e rinunciare alla battuta di caccia. Anticamente in Cadore si usava entrare in casa prima con la gamba destra guardando bene di non inciampare sulla soglia, poi con la sinistra. Era di ottimo augurio per le nozze o per un battesimo spargere sulla tavola il vino, spargere il sale invece indicava che sulla famiglia stava per abbattersi una disgrazia. Il sale era considerato sacro, tenendo in tasca un cartoccio contenente un po’ di sale, si credeva di poter tener lontani l'diau, gli spiriti del male, le strie e i strioi.
Se una persona seduta a tavola parlava di incendi il padrone di casa buttava acqua sotto il tavolo per scongiurarli. Se qualcuno lasciava cadere a terra un pezzo di carne doveva mangiarlo così com'era o cremarlo nel fuoco del larin. Se il latte cadeva sul fuoco si credeva che la vacca dal quale era stato munto avrebbe contratto una malattia o sarebbe morta.
Le farfalle pavee, erano rispettate perché ritenute esseri benedetti da Dio "andoi del paradis che va a rencurià i fiore". Se una pavea entrava in una stalla e spegneva il lume per tre volte le donne scappavano perché dicevano che sarebbe crollato il tetto del fienile. Le pavee notturne erano ritenute da alcuni le anime delle persone morte di suicidio. Il martorèl era uno spauracchio che girovagava vestito di bianco e offriva ai bambini più cattivi pane e latte per prenderli e portarli via con sé. Per allontanarlo si diceva "vignè doman che ve dason pan e sal".
Le lucertole in Cadore venivano considerate innocue e i bambini le legavano con uno spago per giocare e addomesticarle. Ad Auronzo però si riteneva che le lucertole più grandi fossero velenose e si raccontava che quando Dio creò il mondo, chiese alle lucertole se preferivano gli occhi o il veleno e che queste risposero: "veleno". Lo stridere del corvo e del gufo, il gallo che cantava a mezzogiorno, le campane che suonavano mentre battevano le ore, un tarlo in azione nella stanza di un ammalato, erano segnali di prossima sventura.
Le stries del Cadore si davano appuntamento nelle notti di luna piena sul Monte Rite.
Là danzavano in cerchio intorno a una pojata, emettendo grida e ululati propiziatori prima di preparare le loro pozioni magiche. Il toponimo Rite deriverebbe appunto "da i rite de le stries". I corvi erano ritenuti anime raminghe dei dannati e si credeva che se un corvo si posava sul tetto di una casa, entro 90 giorni sarebbe morto un inquilino della stessa.
Una leggenda racconta dei tre croàs (corvi) che durante la notte volano sopra la montagna di Bajon, una località posta a sud delle Marmarole sopra Calalzo e Domegge di Cadore.
I tre corvi sarebbero tre anime condannate alla dannazione eterna per aver giurato il falso allo scopo di diventare proprietari della montagna di Bajon. Questi tre uomini di Domegge, furono chiamati a giudizio nel castello di Pieve di Cadore per una vertenza che gli vedeva contrapposti ai regolieri di Calalzo, per la proprietà della montagna di Bajon.
Sapendo che prima di iniziare la discussione della causa avrebbero dovuto giurare di dire tutta la verità, prelevarono una manciata di terra dall'orto davanti alla loro abitazione e la inserirono all'interno delle loro dalmede (calzature di legno). Quindi giurarono di thapàr sul sò (di calpestare la terra di loro proprietà) e così diventarono proprietari della montagna di Bajon ingannando i giudici e sé stessi, ma quando morirono furono condannati a trasformarsi in corvi e a girare tutte le notti sopra i terreni rubati con il falso giuramento.
A proposito del cuculo che egoisticamente va a deporre le uova nei nidi degli altri: quando un giovane dopo il matrimonio andava a vivere nella casa della moglie, condividendo la proprietà e lo stesso segno di casa, si usava dire: "è desto cuco, è desto su la roba".
Quando il cuculo cantava molte volte vicino a una ragazza si diceva che questa sarebbe rimasta zitella. A Sacco, una località nei pressi del cimitero di Borca di Cadore quando facevano il fieno si diceva che il cuculo non cantava più perché sua madre era morta sotto un covone. Una filastrocca che si insegnava ai bambini recitava: Cuco de mei (maggio), cuco de tei, cuco de febarei (febbraio), cuco de la coda lissa cuante ane me dasto gnante che sea noitha? Cuco de la coda storta cuante ane me dasto gnante che sea morta?
La reduoia o redodesa
La redodesa a mezzanotte di una vigilia dell'Epifania si presentò nella chiesa di San Giovanni a Calalzo di Cadore per essere battezzata. San Giovanni la mandò alla vicina fontana con una cesta bucata per prendere l'acqua necessaria per la cerimonia. La redodesa provò più volte a riempirla d'acqua, ma senza successo. Ritornata dal Santo con la cesta vuota dovette andarsene senza ricevere il battesimo. Un tempo in Cadore la sera dell'Epifania i bambini andavano in giro per i paesi armati di ciadene, sampogne e racole per sfidare la reduòia.
I ragazzi invece issavano nella piazza principale del paese un palo alto la cui cima era riempita di paglia che veniva incendiata (il pearvò) allo scopo dicevano di illuminare la strada ai tre Re Magi. Le ragazze invece si rinchiudevano in casa, lucidavano e ritiravano le catene del larìn e poi andavano a letto. Una antica leggenda racconta che una vigilia d'Epifania di molti anni fa, alcune ragazze stavano slittando con la liòda lungo le borgate Paìs e Zardùs di Auronzo insieme ai loro fidanzati.
Ad un certo punto sbucò dal buio la reduòia e preso il comando della liòda , fece cadere nella neve tutti i ragazzi. Poi condusse le ragazze che urlavano di paura nelle acque del fiume Ansiei dove annegarono tutte.
Un'altra leggenda racconta di una ragazza che, chiusa nella sua casa stava preparando il corredo per le nozze che erano state previste per la prossima primavera. Per questo motivo stava filando la lana sul corleto anche la notte dell'Epifania. Le sue sorelle erano sedute intorno al larìn attizzando il fuoco e cantando una antica nenia.
Ad un tratto la porta si spalancò di colpo ed entrò la reduòia che, data una rapida occhiata in giro, si diresse verso la ragazza che stava filando, chiedendole un secchio di rame per andare al fiume a prendere dell'acqua. Una delle sorelle, più intelligente delle altre pensò di darle due cesti di vimini invece dei secchi di rame. La reduòia si avviò con il thampedon in spalla verso il fiume dove per tutta la notte tentò invano di riempirle.
Alle prime luci dell'alba, stanca morta abbandonò le ceste e fuggì non si sa dove.
Così le ragazze furono salve.
Per questo motivo ad Auronzo la vigilia dell'Epifania veniva vissuta con tristezza e tutte le ragazze si chiudevano in camera mettendosi a letto. Qualcuno ricordava la reduòia come una vecchia che diventava talmente grande da riuscire a sbarrare completamente la strada principale del paese e nessuno poteva transitare senza il suo permesso.
A Borca prendeva il nome di donnazza e la sera dell'Epifania i ragazzi attaccavano dietro all'audeta (slitta) una fascia di paglia alla quale davano fuoco correndo intorno al colle dicendo "bruson la coda a la donnazza" Sempre nella valle del Boite ma anche a Santo Stefano di Cadore e nel Comelico in generale le donne non lasciavano la stoppa sul corletto e spargevano acqua santa per tutta la casa per paura che la reduòia entrasse in casa.
Ogni paese del Cadore recitava una filastrocca sulla reduòia. A Cortina d'Ampezzo: Leva su burta slavatha fira do ra to rociada, se no vien ra scancagnara e ra porta via l'panegel. Ad Auronzo: Leva su desconculiada fila do la tò rociada se no rua la reduoia a ciatate inthe de coa. A Costalta: Leva su compissèda fila du la tò roceda s'no t'la filarei di iè. A Padola: Levè su pultronelle filè du le to rucele levè su pultrunate filè du le to rociate.
Le anguane
Secondo alcuni studiosi questo nome deriverebbe da Adganee antiche deità celtiche. Ma in Cadore assumevano nomi diversi: Ongane o Longane a Lozzo, Agane ad Auronzo. E' molto difficile stabilire l'antico nome originario che doveva essere simile in tutto il territorio, perché la loro descrizione coincide in quasi tutti i paesi cadorini: donne bellissime con i seni molto grandi che trasportavano i loro bambini in una specie di gerla appesa sulle spalle, sapevano ricamare molto bene e venivano osservate soprattutto quando scendevano a valle per lavare i panni nel fiume.
Abitavano nei landres (caverne) e conoscevano l'arte della magia che usavano generalmente in modo positivo, ma se costrette a difendersi erano capaci di fare molto male e per questo vennero perseguitate, definite "stries coi pès de ciaura e co le tete tanto longie che le podea biciale davoi la schena por da da magnà ai so fioi, le podea fei vegnì le saete cuan che le volea e dà fuogo a le ciase solo vardandole".
A Fontanelle sopra Lozzo di Cadore c'è il Crepo de le Ongane dove abitavano e facevano il bucato nei giorni di pioggia. Con la pioggia infatti si vedeva uscire un rivolo di acqua sporca che la leggenda voleva provenisse dai panni sporchi lavati dalle Ongane.
Alcuni studiosi ritengono che il loro nome derivi da acquane cioè le benefiche ninfe pagane delle fonti che con l'avvento del cristianesimo furono perseguitate e definite malefiche. A Cortina d'Ampezzo erano state viste nel lago Bai de Dones, nel lago Ghedina e al lago Scin e si riteneva che fossero in grado di scatenare anche la tempesta.
A Cortina fino ai prime del novecento si raccontava che alcune famiglie conservavano dei magnifici fazzoletti ricamati dalle anguane A San Vito di Cadore le anguanes abitavano in un antro della croda Marcora e nel pianoro di Senes. A Perarolo sui piani di Dubiea nel Bus de le Anguane. Ad Auronzo gli anziani raccontavano delle Agane Pès de Ciaura (perché indossavano calzature fatte con la pelle della capra), in seguito confuse con le Pagane che come confermano alcuni ritrovamenti archeologici, vivevano un tempo a Malòn sul monte Agudo, ma anche a Stabìn, a Rònce e a Porìn.
La memoria trasmessa dagli anziani vuole che le Agane scendessero di notte con la luna piena per lavare i loro panni sul fiume Ansiei, che fossero molto allegre e che cantassero delle canzoni con parole incomprensibili.
A Buenos Aires in Argentina mi raccontarono che i pagani che abitavano sul Monte Agudo fossero stati uccisi tutti a uno a uno e che l'ultima donna mentre moriva schiacciata sotto una grossa pietra, avesse lanciato una maledizione contro gli assassini che sarebbe durata per cento generazioni.
A Domegge in località Deppo c'è la Busa de le Anguane che è molto profonda ed anche il Crepo de le Anguane.
A Pieve, Calalzo e Vallesella secondo la memoria popolare, le Anguane vivevano a Lagole località conosciuta per i notevoli ritrovamenti archeologici di era protostorica.
A Calalzo si raccontava che all'interno di alcune caverne erano stati rinvenuti dei sassolini dipinti si riteneva dalle anguane e che nelle vicinanze di quegli antri erano state rinvenute le loro orme a forma di zoccolo di capra sul terreno. Sempre a Calalzo si raccontava che fino al secolo scorso alcune famiglie conservavano alcune statuine di donne con i seni annodati dietro la schiena e con i piedi a forma di zoccoli di capra. Una leggenda racconta che un uomo di Calalzo sposò una bella Anguana.
Vissero felici e contenti per alcuni anni ed ebbero tre figli. Una sera il marito ritornò a casa un po' alticcio e le disse: dute me ride sora porce che me soi maridà con una Anguana da i pes de ciaura". Appena pronunciata quella frase la donna sparì e da quel giorno il marito divenne triste e taciturno. Incominciò a girovagare per le crode gridandole di ritornare, ma l'unico favore che gli faceva la moglie, era di continuare di nascosto e mai in sua presenza a mantenere pulita la casa e a governare i figli. La popolazione di Calalzo, vedendo che come per incanto i ragazzini erano sempre puliti e ben vestiti e la casa tenuta in ordine da mani invisibili, incominciò a parlare di stregoneria e decise di farla finita con le Anguane.
Riunitosi in assemblea decisero di recarsi da un eremita che viveva in un antro nella Val d'Oten, portandoli formai, onto e puina (formaggio, burro e ricotta) e gli chiesero di usare i suoi poteri magici per farle sparire tutte per sempre.
L'eremita con fama di stregone organizzò una grande festa sotto alle Marmarole e invitò le Anguane a parteciparvi. Inviò un carro adorno di rami d'abete, stelle alpine e rododendri a prendere le Anguane che si erano preparate per l'occasione vestite dei loro abiti più belli adornati con splendidi ricami.
Quando il carro arrivò quasi in fondo alla Val d'Oten sbucò dal bosco l'eremita che con una bacchetta di legno di pagogna (viburno) in mano pronunciò le parole magiche: "N' nome de Dio e de la Madona ciar e rode dute de pagogna" Come d'incanto il carro scomparve con tutte le Anguane e da quel momento nessuno le ha più viste.
A Pieve di Cadore invece i vecchi raccontavano di un bacàn (possidente) di Nebbiù che con il suo carro trainato dai buoi in un giorno d'autunno andò a Lagole a prendere pietre di tufo. Qui incontrò le Anguane che avevano lavato una gran quantità di panni, tanti che nemmeno un carro poteva trasportarli. Queste credendo di prenderlo in giro gli proposero che se fosse riuscito a trasportare tutti i panni con il suo carro, avrebbe potuto tenerseli. Il bacàn vista una pianta di pagogna (viburno) ne tagliò un ramo e ne fece una croce che pose sul carro, quindi iniziò a caricare i panni, ma giunto a metà dell'opera si accorse che il carro era pieno e che non c'era posto per tutti, allora pronunciò la frase "N' nome de Dio e de la Madona dute le masarie sora la cros de pagogna" e come d'incanto il carro si riempì di tutti i panni e i buoi partirono lasciando le Anguane senza niente.
A Vallesella di Domegge di Cadore si raccontava invece di uno spaccalegna che si recava tutti gli anni a Venezia a servizio di una ricca famiglia. Durante il viaggio ed essendosi fatto buio, bussò a un casolare chiedendo ospitalità. Due donne gentili lo accolsero e dopo avergli preparato una buona cenetta lo accompagnarono a dormire in un granaio. Ma egli spinto da un presentimento uscì e di soppiatto e raggiunse la finestra della cucina dove le due donne stavano facendo le pulizie e si mise a origliare di nascosto.
Una di loro stava dicendo che conosceva quell'uomo, che sapeva da dove veniva e che una settimana prima sua moglie aveva dato alla luce un bel bambino in una baita tra Domegge e Vallesella. Poi finite le faccende domestiche si unsero la testa con un unguento dicendo "A Vallesella andon a far un sanfason" e di colpo sparirono attraverso il camino.
Lo spaccalegna entrò in casa e seguendo il loro esempio si unse il capo con l' unguento che era rimasto sul tavolo della cucina, quindi pronunciò le stesse parole e come d'incanto fu spinto da una forza misteriosa attraverso il camino ritrovandosi d'un attimo nella sua baita di Vallesella. In fretta e furia si munì di una manèra (ascia) e corse a sprangare la porta, ma nello stesso istante si accorse di due gatte nere che stavano entrando da una finestra, egli velocissimo con un colpo d'ascia ben dato amputò loro le zampe posteriori ed esse gridando di dolore scomparvero gridando "Anguane Anguane aiudane".
Il giorno dopo quando lo spaccalegna riprese la via per Venezia e si fermò a sbirciare attraverso la finestra nel casolare delle due donne: queste stavano piangendo di dolore guardando i moncherini dove prima erano attaccate le mani.
Per gli abitanti di Cibiana e per quelli di Vodo le Anguanes abitavano sul Monte Rite.
In Comelico, dove è ambientata la leggenda che raccontavano in quei luoghi fino a non molti anni fa, venivano dette Anghènes:
L' Anghèna Azana viveva solitaria e felice sui prati a sud di dove ora si trova Santo Stefano di Cadore. Un giorno mentre stava lavando i panni sul fiume Piave, i suoi occhi di un azzurro intenso si incontrarono con quelli di un bellissimo giovane, che munito di anghièr stava disincagliando una grossa taja (tronco d'albero) che si era incastrata dietro a un masso durante la menàda (fluitazione del legname). Il giovane era sposato da poco e innamorato della moglie, ma i splendidi occhi di Azana lo stregarono e senza dire una parola abbandonò il lavoro di menadàs per seguirla e vivere con lei.
La moglie lo attese invano e preoccupata per la sua sorte scese fino al fiume dove trovò l'anghièr abbandonato. Un compagno di lavoro del marito le raccontò tutto ed ella disperata ritornò a casa sperando nel suo ritorno. Ma dopo alcuni giorni, ormai stanca di piangere, decise di mettersi in cammino verso Casamazzagno nel Comelico Superiore dove le avevano raccontato abitasse una donna dotata di poteri magici. Raggiunta la sua baita che si trovava sopra l'attuale chiesa di San Leonardo, entrò e dopo averle regalato una forma di formaggio e del burro, le raccontò tutto e la implorò di far morire l'Anghèna affinché suo marito, una volta liberato dall'incantesimo dei suoi bellissimi occhi, potesse ritornare da lei.
La donna dai poteri magici la assicurò che avrebbe provveduto e alcuni giorni dopo quando Azana si recò sul fiume a lavare i panni scatenò un terremoto le cui scosse fecero cadere dalle falde del Monte Tudiai dei grossi massi che la seppellirono. Il giovane che stava dormendo in un landro, venne svegliato dal frastuono della frana e corse verso il fiume per tentare di proteggere Azana, ma un sasso lo colpì sul capo e cadde morto in mezzo al Piave.
Nelle vicinanze del lago Scin, nella conca di Ampezzo si raccontava vivessero alcune Anguane bellissime ed abili nel lavoro di ricamo. Un giorno mentre stavano lavando i panni che stendevano ad asciugare sui prati, passò di là un pastore che agitando il bastone le fece scappare, quindi gettò nel lago tutti i loro panni. Il pastore fischiettando scese fino ad Alverà dove lo attendevano moglie e figli.
Finito di cenare la moglie fu colpita da un terribile mal di pancia. Il male continuò anche nei giorni successivi e il pastore salì fin sotto al Monte Cristallo dove in un landro viveva un vecchio eremita. Questi individuò nello sgarbo fatto alle Anguane la causa della grave malattia che stava consumando sua moglie e gli consigliò di recarsi da loro a chiedere perdono portando in regalo un capretto nero.
Il pastore seguì il consiglio dell'eremita, ma tutto fu invano perché dopo pochi giorni la moglie morì. Una Anguana mossa a pietà attendeva che il pastore si recasse con capre e pecore sugli alti pascoli sotto alle crode e scendeva di nascosto ad accudire i figli pettinandoli con un bellissimo pettine d'oro. Tutto ciò per anni finché i bambini furono in grado di sbrigare le faccende domestiche da soli. Una mia antenata che abitava a Alverà e che faceva parte della famiglia degli Alverà Venteselo, raccontò che suo nonno conservava ancora il pettine d'oro, dimenticato nella loro casa alcuni secoli prima dall'Anguana.
L'Matharuò
In Argentina ho sentito raccontare che il Matharuò viveva un tempo tra i ruderi dell'unica opera in muratura rimasta in piedi a Treponti dopo la distruzione della città di Agonia avvenuta da parte di Attila e degli Unni.
Si dice che egli abitasse là per fare la guardia al tesoro di Agonia che era stato sepolto poco prima della resa agli Unni. Non avevo mai sentito questa leggenda, eppure fin da piccolo ho ascoltato i racconti e le minacce su questo essere fantastico che vestito di verde con la berretta rossa, i pantaloni al ginocchio, si divertiva a fare il burlone, a zufolare nei boschi e a far perdere il sentiero ai viandanti.
Raccontavano che quando si indossava una maglietta o un capo di abbigliamento al rovescio era facile perdese po l'truòi del Matharuò. Ad Auronzo era famoso per invitare le bambine e le ragazze a seguirlo, facendole camminare per giorni, inducendole ballare in mezzo a un prato, senza però far loro niente di male. A Bradford in Pennsylvania ho conosciuto la zia di una bambina di Reane che si perse nel bosco in Val da Rin e fu rintracciata a Malòn dopo una settimana, dimagrita ma sorridente.
Raccontò che aveva trascorso tutto quel tempo con il Matharuò che l'aveva portata fin sotto le rocce delle Marmarole. Qui in un landro avrebbe riposato bevendo latte de ciamortha e mangiando frasène e giasène a volontà. Finche un giorno l'omino la invitò a seguirla per abbandonarla nei pressi dei tabiàs de Malòn Bàs. Possiedo anche la foto di quella bambina, ma mi è stato chiesto di non rendere pubblico né il suo nome né la sua immagine. A Pieve di Cadore il Matharuò era famoso quanto l'Orco, un uomo vestito di nero in grado di prendere tutte le forme che voleva.
A volte prendeva le sembianze di un animale, a volte diventava un gemo de refe o un sacco di farina. Si divertiva in particolare a burlarsi di coloro che si credevano furbi. Intere generazioni di cadorini sono cresciuti con lo spauracchio del Matharuò e dell'Orco: " varda de no mete l'pè inthe de le thapole del Matharuò" e ancora "varda de fei polito a scola se no rua l'Matharuò a portate via" ecc.
Mi ricordo che una sera mi avevano tanto spaventato con i racconti delle loro malefatte che uscito al buio per prendere un braccio di legna, mi parve di sentire qualcuno soffiarmi sul collo, allora sono rientrato a casa correndo senza la legna, tra le risa della nonna e dei miei genitori.
Un'antica leggenda parlava anche di uno Strion che riusciva a trasformarsi in un grande cavallo grigio: L' Ciaval Grìs che correva imbizzarrito a rapire le ragazze più belle. Con il passare del tempo molti hanno confuso L'Ciaval Grìs con L'Orco e questi con il Matharuò e quest'ultimo con L'On Salvargo, ma oltreoceano mi hanno assicurato che erano tutti esseri fantastici distinti, che hanno popolato la fantasia e la vita dei cadorini per generazioni e che è bene ricordare perché parte della nostra cultura di popolo delle Crode.
Copyright 2007-2016: Giovanni Pais Becher (Gianni)
Via Aiarnola 33*32041Auronzo*Italia* All rights reserved
Estratto dal libro "Il Cadore degli Emigranti" scritto da Giovanni(Gianni) Pais Becher nel 2000 e pubblicato con un finanziamento della Comunità Europea
|